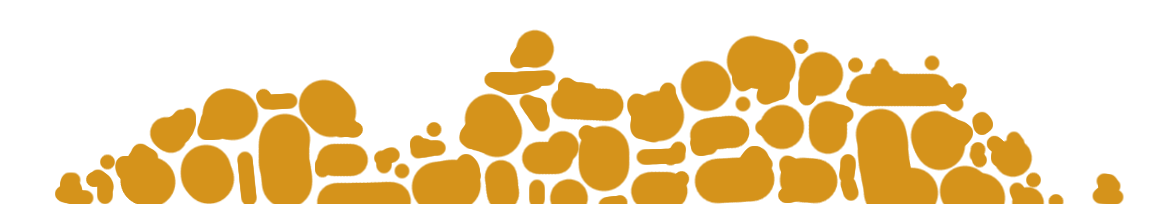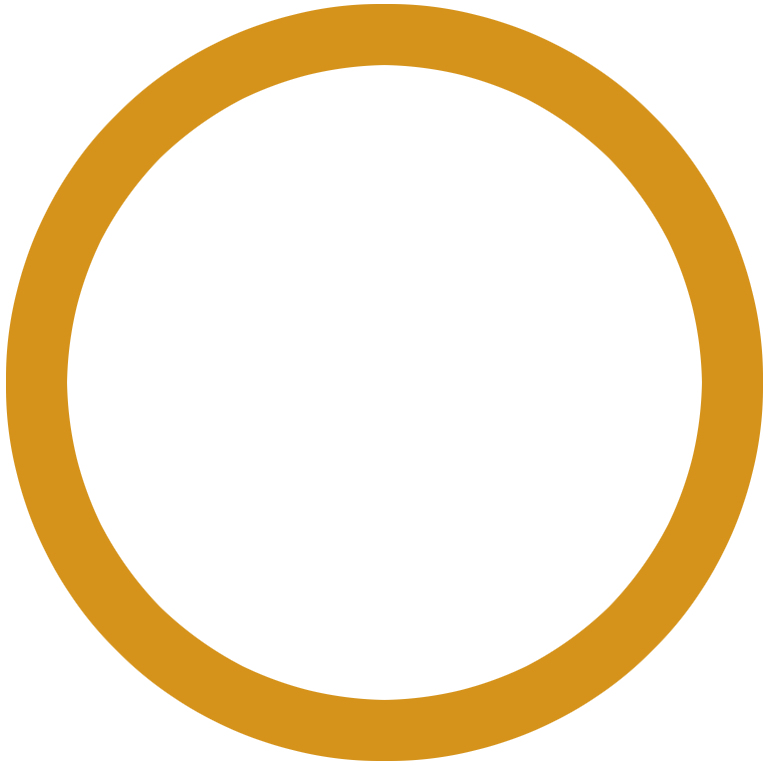Il centro storico di Lecce è una fonte inestimabile di storia e testimoninze pervenuteci dal passato sfidando secoli di abbandono, di rifacimenti, di incursioni piratesche, di dominazioni. Ormai risulta impossissibile eseguire anche semplici lavori di rifacimento del basolato delle strade costeggiate da chiese barocche, senza riportare alla luce antiche terme romane, come nei pressi della chiesa di Santa Chiara, complessi oleari ipogei del I secolo a.C., sotto la piazzetta Sigismondo Castromediano, o veri e propri complessi messapici come quelli presenti nell’Edificio Storico Archeologico Faggiano, sito in via Ascanio Grandi al civico 56.
Quello che ora si può ammirare, tra stanze e cunicoli a vari livelli di profondità, fino ad una decina di anni fa era del tutto sconosciuto, nascosto nella mura di quello che si riteva essere esclusivamente il convento femminile di Santa Maria delle Curti, chiuso intorno al XVI-XVII secolo, di cui rimangono le tracce delle cellette delle suore nei muri del primo piano dell’abitazione.
Cominciati gli scavi quasi per un assurdo scherzo del destino, il museo Faggiano è stato in un certo senso vittima delle burocrazia e delle istituzioni responsabili in materia, prima che gli venisse in qualche modo riconosciuto il valore e lo sforzo profuso per riportare alla luce più di 2000 anni di storia salentina. I lavori di scavo sono stati infatti finanziati dalla stessa famiglia Faggiano sotto la supervisione della Soprintendenza dei beni archeologici di Taranto e sotto la guida degli architetti Franco e Maria Antonietta De Paolis.
1 commento