Aggiornato il 27 Ottobre 2025
Tempo di lettura: 4 minutiIl parco archeologico di Parabita ha consentito di preservare e far conoscere alla comunità salentina alcune degli aspetti della storia di questa incredibile terra probabilmente, anzi no, sicuramente, sconosciuta ai molti. Una piccola città talmente famosa da essere menzionata anche all’interno dei libri di storia dell’arte, nel capitolo relativo all’”arte preistorica”, quando la quasi totalità degli aspetti della storia occidentale taggati con “Salento” vengono oscurati o eclissati. Il sud resta ai margini dell’impero.
Pochi mesi fa la svolta: l’attribuzione di due molari rinvenuti negli anni sessanta all’interno della grotta del Cavallo, nella baia di Uluzzo, in territorio neretino, ai primi uomini del genere Sapiens in Europa. I più antichi resti fin’ora rinvenuti e risalenti a ben 45.000 anni fa. In prima pagina su tutte le testate giornalistiche e riviste specializzate di tutto il mondo il Salento ha avuto il suo momento di notorietà. Ma abbiamo ancora molte storie da raccontare. La grotta delle Veneri di Parabita è una di queste.

Si tratta di una cavità carsica, scavata dall’azione erosiva dell’acqua penetrata nel sottosuolo nel corso di millenni, composta da un primo ambiente di modeste dimensioni e di un cunicolo che si articola a forma di T per un centinaio di metri. All’esterno della cavità un secondo “ambiente” comunemente conosciuto come grotta-riparo, formatasi probabilmente con la graduale riduzione dell’ambiente carsico primordiale inseguito a fenomeni di crollo della volta. Questo aspetto è stato confermato con un saggio di scavo nel 2025 che ha indagato una porzione di terreno immediatamente antistante il riparo con il rinventimento di frammenti di ossa e ceramiche al di sotto di grossi massi..
La Grotta delle Veneri si apre in corrispondenza del piede del gradino morfologico che collega la superficie terrazzata di quota 125m con quella immediatamente successiva, a quota 100 metri circa. Da questa posizione domina verso ovest la successione di terrazzi marini che digrada verso mare sino all’attuale linea di riva.

Le indagini archeologiche in questi ambienti ha prodotto risultati notevoli. Sono stati rinvenuti reperti appartenenti ai Neanderthaliani e Cromagnoidi per un intervallo temporale che spazia tra i 35.000 e 10.000 anni fa: numerosissimi elaborati d’arte mobiliare e litica del paleolitico; ben 18.000 frammenti di ceramiche risalenti ad un periodo compreso tra il Neolitico e l’età del bronzo; 400 manufatti d’arte su pietra e su frammenti d’osso decorati con motivi geometrici; resti di una sepoltura di un uomo e una donna di Cromagnon con tanto di corredo funerario composto da un ciottolo e un scheggia di selce tinti d’ocra e 29 canini di cervo forati. La sepoltura è stata danneggiata durante il Neolitico e parte degli scheletri è stato asportato ma, da un rilievo rappresentato su uno dei pannelli illustrativi posti nello spiazzale antistante la grotta, si può poeticamente immaginare che i due corpi fossero uniti quasi in un tenero abbraccio, uno sovrapposto all’altro. Una recente datazione collocherebbe la sepoltura a 24410 BP ± 320 anni. Coeva alla gestante di Ostuni di Santa Maria d’Agnano.
Il complesso litico del musteriano trova similitudini con quello rinvenuto in Grotta del Cavallo a Nardò, anche questa appartenente ad una fase terminale del Paleolitico medio: stesso equilibrio tra le materie prime sfruttate, con prevalenza di calcare locale sulla selce esogena: 163 elementi in pietra prevalentemente calcarea, 53 raschiatori, rare lame ritoccate.
Dalla grotta sono stati recuperati sommariamente:
3390 oggetti dell’Epiromanlelliano
1121 oggetti in selce garganica
35 supporti in ossidiana
Sia all’interno che all’esterno della grotta è stato individuato uno strato di paleosuolo contenente reperti dell’Uluzziano, una fase transitoria tra neanderthal e sapiens: 33 elementi litici in totale che invece sfruttano principalmente la selce al posto delle selce locale.
A questi si aggiungono un numero spaventoso di reperti spesso di difficile attribuzione. Il paleosuolo è stato soggetto nel corso del tempo a continui rimescolamenti dovuti sia alla continua frequentazione della cavità, a più riprese fino al medioevo, che a scavi clandestini occorsi soprattutto negli anni successivi allo studio di Cremonesi negli anni ’70.
Un reperto del paleolitico superiore merita però una menzione a se: un frammento di pietra con tracce di bitume, probabilmente parte di un’arma da caccia e che, con le dovute cautele, potrebbe attestare il più antico utilizzo del bitume nell’Europa Occidentale a 15.000 anni fa (contro i 40.000 di un reperto rinventuo in Siria).
Un reperto con tracce di bitume potrebbe attestare in Grotta delle Veneri il più antico utilizzo di questo legante nell’Europa occidentale!
Ma senza ombra di dubbio il ritrovamento che ha fatto conoscere questa grotta in tutto è mondo è costituito da due piccole statuine in osso, le famose Veneri di Parabita. Sono queste che danno il nome alla cavità e che consentono di collocare Parabita in una delle decine di cartine che contrassegnano i luoghi in Europa nei quali sono stati ritrovati dei reperti simili: nei Pirenei, in Siberia o nelle pianure Russe e Ucraine.
Le Veneri, del cui aspetto nulla può essere messo in relazione con la dea Romana, controfigura dell’Afrodite greca, raffigurano donne dalle pronunciate forme, con il pube,il ventre, i fianchi e i seni ben in evidenza. Raffigurazioni della Grande Madre, l’impersonificazione della fertilità, non si conosce ancora la musa ispiratrice. Si sa solo che sono tutte diverse tra loro, originali, individuali, anche se i due esemplari rinvenuti a Parabita presentano alcune analogie con quelli russi: braccia lungo i fianchi e mani che si congiungono sotto il ventre.
Sono estremamente piccole, appena 9 e 6,5 centimetri, ma estremamente importanti del punto di vista antropologico. Sono entrambe senza volto ma mettono magnificamente in evidenza la loro età, tra i 10.000 e i 12.000 anni. Fisico non proprio asciutto, in controtendenza rispetto ai dettami della moda, ma portatrici di un desiderio di fertilità, di vita, scolpito dalle mani di un homo di cui non conosciamo l’identità ma che è giunto fino a noi, indenne.
La grotta è in un progetto di riqualificazione volto alla fruizione turistica del bene a conclusione delle nuove campagne di scavo, avviate nel 2022, che dovrebbe giungere a termine nel 2027.
Marco Piccinni
BIBLIOGRAFIA:
Museo Archeologico di Taranto. Scheda Veneri di Parabita
Elettra Ingravallo, Renata Grifoni Cremonesi (a cura di), La grotta delle Veneri di Parabita (Lecce), 2020 EdiPuglia


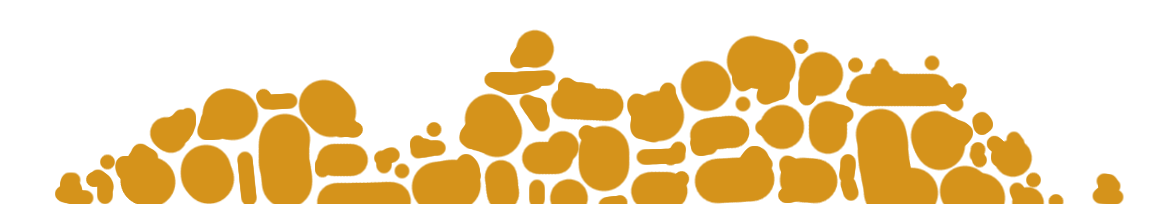

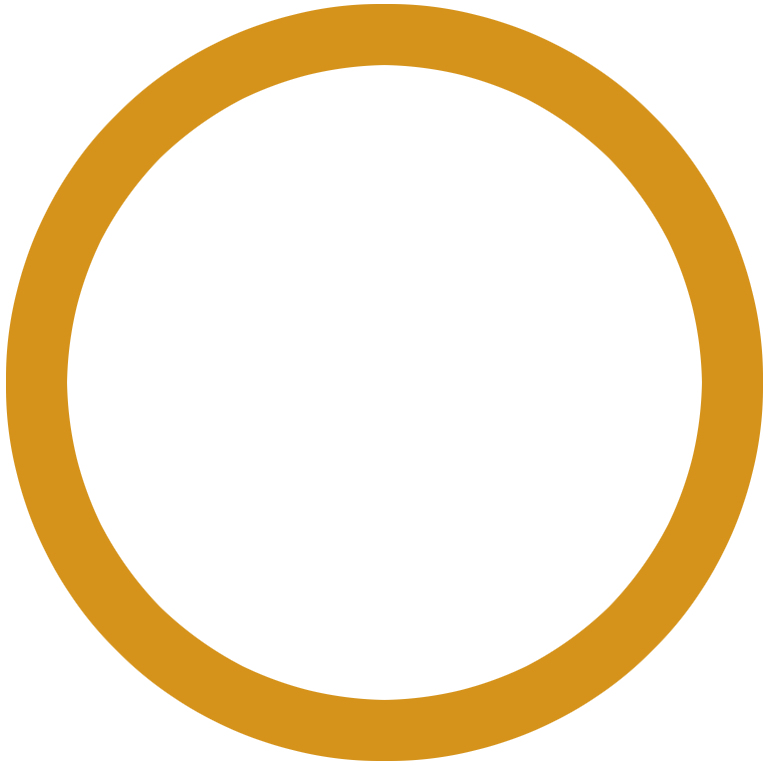
una scoperta inaspettata, la Venere di Parabita è stata ispiratrice della mia opera fotografica denominata “Futuro Remoto” che ha come elemento principale la donna generatrice di vita inserita nei 4 elementi primordiali.