Aggiornato il 14 Settembre 2025
Tempo di lettura: 4 minutiLa mietitrebbia giunge puntuale sotto il sole cocente di giugno, pronta a divorare l’ennesimo campo di grano, il terzo della giornata. Si tuffa quasi con eleganza, nonostante la mole e il rumore, in quella distesa dorata dal sole che da li a pochi minuti non ci sarebbe stata più.
Il contadino, che ha seminato e assistito ognuna delle centinaia di migliaia di spighe che compongono quell’incantevole fazzoletto di un giallo intenso, con diverse sfumature in diverse gradazioni di marrone, osserva quasi con commozione ogni passo compiuto dalla macchina. Ne studia la traiettoria mentre fagocita con tanta voracità quasi 10 mesi di fatiche. Gli torna allora alla mente quanto fosse complicato e duro, una volta, il lavoro di mietitura.
Ripercorre quindi la sua infanzia con il sorriso sulle labbra e l’occhio lucido, senza distogliere neanche per un solo istante lo sguardo dalle sue spighe, tornando a quando il grano si mieteva con una falce in una mano e dei ditali in canna che proteggevano almeno tre dita dell’altra, quelle in prossimità delle quali si sarebbe reciso un fascio di spighe strettamente raccolte nel pugno.

Le immagini nei ricordi e nella mente del contadino cominciano a sovrapporsi a quelle reali e, accanto alla mietitrebbia, compaiono delle figure, i suoi genitori, così come li ricordava tanti anni addietro. Procedono in linea retta, uno dietro l’altro, falciando di volta in volta il grano che si trovano innanzi. Ed ecco che più a sinistra si intravedono anche i suoi zii e i suoi cugini. La mietitura del grano era un vero e proprio affare di famiglia. Tutti dovevano partecipare! Gli occhi di questi contadini non vedevano nel grano ore e ore di lavoro sotto il sole cocente, ma la farina che ne avrebbero ricavato e con la quale avrebbero sfamato la propria famiglia nell’anno che sarebbe seguito.
Il capofila preparava piccoli fasci di spighe di grano, “molto più alto di quello che si coltiva ora”, ci tiene a precisare il contadino. Le spighe venivano utilizzate anche per legare le fascine. Ogni fascina veniva chiamata sciermete, che legata insieme ad altri sciermiti foramava lu mannucchiu (il covone). I mannucchi venivano tenuti insieme con le crucicchie, delle vere e proprie corde ricavate intrecciando molte spighe tra di loro. Ogni spiga doveva assumere la sua posizione all’interno del covone e nessun errore sarebbe stato tollerato!
Ciò che restava del grano dopo la mietitura prendeva il nome di ristuccia, la parte della spiga ancora legata al terreno con la sua radice. Anche questa era molto alta, a seconda dell’altezza alla quale veniva recisa la spiga. Camminare nelle ristuccia poteva essere estremamente fastidioso: era facile graffiarsi e impediva di muoversi agilmente nel campo già mietuto.
Al termine dell’operazione di mietitura tutti i mannucchi sarebbero stati portati con un carretto nei pressi di un’aia. I bambini dovevano seguire il carro per raccogliere eventuali spighe cadute, per appallottolarle nelle foffule, che sarebbero state poi ributtate sul carro. Nell’aia i contadini battevano il grano con una mazza, la purcara, al fine di separare i chicchi dalla spiga. I più fortunati potevano usufruire dell’aiuto di un animale pesante, una cavallo ad esempio, al quale si legava in vita una pisara, un masso di grosse dimensioni di forma ogivale. Tutta la materia prima che giaceva sull’aia andava ripetutamente smossa, lanciata in aria, per consentirne una prima forma di setacciamento naturale grazie al vento, che avrebbe soffiato via pula e paglia (più leggere) lasciando ricadere i chicchi grano in terra..

Poi i tempi sono cambiati, “sono arrivate le macchine”, il grano non si pestava più a mano ma con le trebbiatrici a motore. Le raccolta avveniva ancora manualmente e, come sempre, si cominciava già a metà Maggio, quando le spighe non erano ancora del tutto dorate. Questo avrebbe impedito che si spezzassero nel preparare le crucicche. Le trebbiatrici a motore non erano su quattro ruote come ora (mietitrebbia). Venivano montate in un podere, statiche, “azionate da un motore e costituite da diversi nastri trasportatori e altri strani aggeggi che facevano tutto il lavoro per noi”, sottolinea il contadino con un segno di stizza sul volto, quasi come a voler reprimere la propria difficoltà nell’esporre il funzionamento di quel processo meccanico.
Tutti i coltivatori portavano i loro mannucchi presso il luogo in cui sarebbe stata montata la trebbiatrice, disponendoli uno sull’altro fino a formare una piramide. In caso di pioggia l’acqua sarebbe scivolata via tra le spighe e avrebbe impedito al raccolto di deteriorarsi. In questo modo al massimo si sarebbe buttato via quello più superficiale. Ogni contadino poneva un segno di riconoscimento per distinguere il suo mannucchiaro da quello degli altri. Chi metteva un ramo di fico, chi uno di ulivo, chi entrambi, oppure nastri colorati o vecchi stracci.
Ogni giorno, fin dall’alba, si procedeva alla trebbiature delle spighe. Ogni mannucchio veniva separato nelle sue componenti, aperte sul nastro trasportatore e trasportate verso un battitore per separare il grano e la paglia di scarto. Questa sarebbe stata ceduta al proprietario del terreno messo a disposizione per l’installazione della trebbiatrice, che poteva a sua volta rivenderla ad allevatori e agricoltori. Mentre gli uomini riempivano finalmente i loro sacchi con il grano tanto sospirato, le donne preparavano a casa una grande tavolata alla quale avrebbero preso parte tutti i membri della famiglia che avevano contribuito alla raccolta.
Nelle comunità più unite ogni giorno di trebbia rappresentava allo stesso modo un giorno di festa. Un lungo progetto (preparare il terreno, seminarlo, concimarlo, accudirlo, difenderlo!) si sarebbe presto concretizzato e avrebbe dato di chè vivere ad un intera famiglia per l’anno successivo (la farina infatti rappresentava un’ottima merce di scambio, un vero e proprio reddito), percui era giusto e doveroso celebrare tutti insieme questo importante evento. Ognuno portava qualcosa, a mali estremi bruschette di pane alla brace con su dell’olio di oliva, due pomodori scattarisciati, e un po’ di vino, sarebbero stati più che sufficienti per accompagnare canti e cunti di quella che di fatto poteva essere definita una grande famiglia allargata.
Nessun ringraziamento alla dea Madre, o allo spirito del grano che, seppur oggi possa far sorridere al pensiero, il sui culto è sopravvissuto ancora fino a non molto tempo fa, con il simbolico omaggio dell’ultimo covone di grano al santo Patrono del paese del contadino.
Il concetto di spirito del grano, abbonadamente esposto da secondo James Frazer sel suo enciclopedico “il ramo d’oro” descrive l’idea che, durante i riti di mietitura, lo spirito vitale del grano si manifesti in forme umane o animali, culminando nell’ultimo covone. Da qui poteva possedere lo sfortunato mietitore che nel peggiore dei casa sarebbe stato sacrificato. Per tale ragione spirito viene andava “catturato”, simbolicamente, e “consumato” attraverso rituali specifici che precedevano il rogo dell’ultimo covone o il consumo di pane e derivati realizzati con la farina dei chicchi provenienti dalle ultime spighe. Questo avrebbe garantito fertilità, rinascita e prosperità al raccolto dell’anno successivo e buona pace per la vita e l’anima del malcapitato mietitore.
Torniamo al presente, la trebbiatrice ha terminato il suo lavoro, il contadino soddisfatto apre i sacchi e si prepara ad accogliere il suo grano. “E’ questo il mio oro!”.

Marco Piccinni



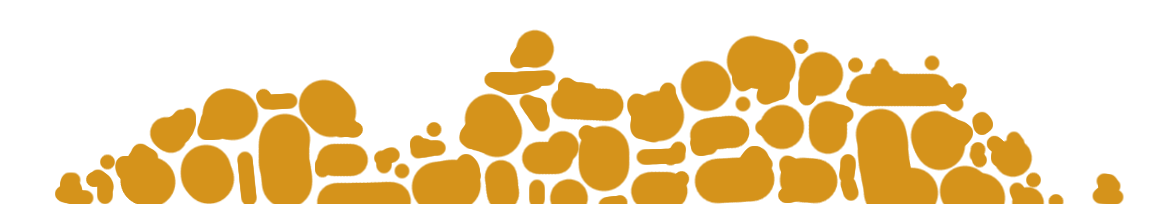

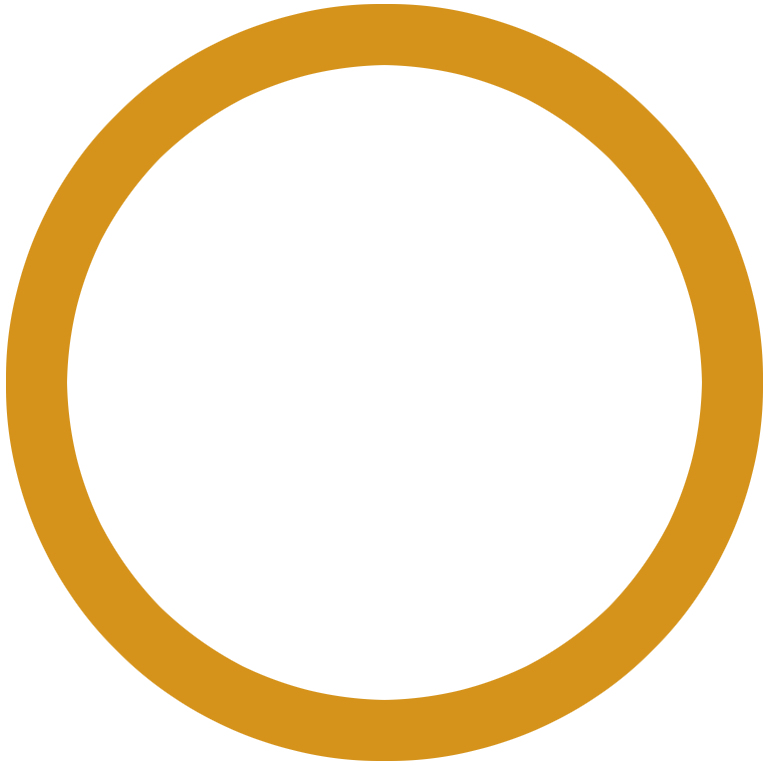
ricordi di fanciullo, la trebbia che si posizionava in campagna e tanti contadini dei dintorni che portavano il loro grano a trebbiare, i canti folcloristici o canzonette del periodo e la sera intorno alla trebbia,alla luce di un faro, a mangiare ciò che avevano portato i vari contadini insieme agli operai della trebbia e racconti tanti racconti sotto le stelle.Ricordi di canti, parole,rumori,e tanti profumi dalla terra arsa alla foglia di fico,usata come piatto, al vino alle cipolle ecc.