Aggiornato il 1 Ottobre 2025
Tempo di lettura: 5 minutiEfeso, Asia Minore – anno del signore 431. Un concilio si riunisce per ribadire che Maria è Madre di Dio. Gesù Cristo, pur essendo contemporaneamente Dio e Uomo, come già ribadito dal precedente Concilio di Nicea, è pertanto un’unica persona nella quale la natura divina e umana si fondono. Maria può essere perciò legittimamente definita come “Madre di Dio”. Nasce così il dogma della Theotókos, colei che genera Dio.
Un atto doveroso, resosi necessario dalle prime comunità cristiane dopo la controversia teologica sollevata dai nestoriani, secondo i quali si avrebbe dovuto far riferimento a Maria semplicemente come “Madre di Gesù”. Questa svolta si riflette nell’iconografia della Santissima Madre, la quale verrà spesso associata all’immagine di suo figlio, reso contemporaneamente bambino e uomo, che sembra Lei tenga sul suo grembo ma che in realtà non sfiora nemmeno. Il bambino con un accenno di calvizie e un po’ di barba sembra quasi levitare sul ventre della Madre.
La Cristianità, motivata dalla consolidata certezza della divinità della Madre di tutte le madri, realizza nuove chiese ed edifici religiosi a Lei dedicati. Il Salento non è da meno, e a soli 19 anni dalla proclamazione del dogma si impegna nell’erezione di quella che di fatto è tutt’ora una delle chiese paleo-cristiane più antiche ancora in piedi: Santa Maria della Croce, più comunemente conosciuta come la Chiesa di Casaranello, piccolo borgo che diede natali (secondo una tradizione non supportata da documenti certi) al papa “guerriero” Bonifacio IX (che in questa chiesa venne battezzato) e progressivamente abbandonato a partire dal X secolo, ed essere poi inglobato dalla vicina Casarano.
Secondo una proposta di datazione della docente universitaria Falla Castelfranchi l’erezione della chiesa sarebbe posticipata di almeno un secolo, facendola quindi risalire al VI sec, contrariamente a quanto hanno affermato fin da subito la maggior parte degli studiosi che si sono interessati all’edificio religioso.

La sua posizione estremamente decentralizzata rispetto all’impero Bizantino, lo sconvolgimento di tutta la Chiesa a seguito dello scisma nonché l’innato impulso di abbandono del vecchio per abbracciare il nuovo che da sempre contraddistingue l’uomo, hanno contributo ad offuscare l’importanza e il ricordo di questo piccolo luogo di culto, più volte rimaneggiato nel corso dei secoli fino a raggiungere la conformazione attuale. Un oblio interrotto solo nel 1907 dall’archeologo Arthur Haseloff, che “riscoprì” gli antichi mosaici del V secolo che adornano la volta absidale e del presbiterio. Le cerchie della storia e dell’arte tornarono a posare lo sguardo nell’estrema propaggine del territorio japigio per ammirare e studiare quello che Haseloff aveva definito come “il monumento più antico ed importante dell’epoca cristiana primitiva nel Sud-Est dell’Italia Meridionale”.
Un mosaico che richiama motivi geometrici tipici dell’arte islamica, arricchiti da elementi floreali e zoomorfi che rappresentano allegoricamente alcuni punti cardine del Cristianesimo. Secondo Gino Pisanò, docente di latino e greco del liceo classico di Casarano, il mosaico di Casaranello è il sesto il linea di successione tra i mosaici Cristiani conosciuti più antichi in Europa, dopo quelli dell’imperatore Costanzo a Tarragona, di Santa Sabina a Roma, di San Giovanni in Fonte a Napoli, del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna e del Battistero di Albegna in provincia di Savona.
Nella cupola a Campana si può ammirare l’Empireo Dantesco con i suoi nove cieli, costituito da una croce giallo oro contornata da un cielo stellato e tre fasce principali, due principalmente monocromatiche, celeste e azzurro, e la terza richiamante tutti i colori dell’iride. I nove cieli rappresentano il modello Tolemaico, il cui universo era composto dalla luna, dal sole, i pianeti interni e di quelli esterni del sistema solare, fino a Saturno, e da stelle fisse. Tutto gravita intorno alla luce splendente del Cristo che ha posto il suo regno sulla Terra, origine del creato e centro propulsivo dell’universo. Quello tolemaico venne ritenuto uno dei contributi più espressivi dell’astronomia antica, rimasto in auge per oltre un millennio e mezzo, dimostrandosi un valido (anche se inesatto) principio mediante il quale motivare matematicamente il moto dei pianeti e le loro orbite.

Seguono alcuni segni eucaristici, una vite rampicante con grappoli d’uva e un melograno (un chiaro riferimento alle comunità Cristiane) che separano il paradiso celeste da quello terrestre, l’Eden, nel quale fanno bella mostra di sé un pavone (la divina regalità) e magnifiche geometrie che simboleggiano la ciclicità degli eventi e che delimitano figure animali (un coniglio, delle anatre, un pesce) e vegetali. Simboli carichi di allegorie e significato che compongono un messaggio di salvezza, un guida per congiungere la terra al Cielo sotto lo sguardo amorevole di Maria, una guida “criptata” e non di rapida e semplice interpretazione. Un’opera forse realizzata da maestranze efesine sbarcate ad Otranto e dirette a Ravenna, nei quali mosaici ritornano i motivi del cielo stellato e della croce.

In origine, tutta l’area presbiteriale doveva essere rivestita da mosaici, così come il pavimento dell’edificio. L’attuale impianto basilicale a tre navate, dotato di un abside quadrangolare molto aggettante, ha avuto varie fasi di rielaborazione sia nella sue forme architettoniche che degli apparati decorativi. Tra le ipotesi più accreditate, si è ritenuto che la chiesa potesse avere in origine una pianta a croce latina con transetto o, più recentemente, che fosse sorta già nelle forme di una basilica a tre navate candite da pilatri, in numero maggiore di quelli attualmente visibili. Non è chiaro chi fosse il committente dell’edificio e il ruolo che la basilica abbia avuto nelle dinamiche di evangelizzazione e di controllo del territorio, sebbene una sua funzione battesimale sia assai probabile [Arthur et alii, 2024].
Il particolare dell’abside quadrangolare ritorna invece in altre strutture molto antiche sempre a carattere religioso come l’abbazia delle centoporte di Giurdignano e la chiesa di San Donato a Taurisano.
Intorno al X secolo giunsero i bizantini, i quali operano sostanziali modifiche al ciclo iconografico della chiesa di Casaranello adottando una progressiva sostituzione delle tessere del mosaico con un ciclo pittorico di affreschi, ancora oggi presenti nella navata centrale, e databili in un arco di tempo compreso tra l’XI e il XIV secolo. Gli affreschi bizantini coesistono con altri di stampo gotico, realizzati nel XIII secolo. Le figure statiche degli arcangeli Michele e Gabriele, di Santa Barbara e della Madonna con bambino si affiancano all’“animazione”, con l’ultima cena, il bacio di Giuda e le scene della misteriosa vita e del martirio di Santa Caterina di Alessandria, la giovane che sfidò i romani e l’ancestrale tradizione sacrificale pagana invitando invece alla contemplazione del Cristo. Un gesto che le costò la cessazione della sua vita terrena dopo il supplizio delle ruota e successiva decapitazione.

Al martirio della santa egiziana si accosta quello di Santa Margherita d’Antiochia, nata da famiglia pagana ma segretamente istruita al Cristianesimo dalla sua nutrice, fede che fece propria al punto di sfidare il padre e andare incontro alla morte per decapitazione, appena quindicenne.
Alcuni dei soggetti raffigurati negli affreschi trovano degli ampi riscontri con cicli iconografici di ulteriori contesti sacri, come ad esempio la chiesa di Santa Barbara a Montesardo.
L’edificio e il vicus di Casaranello dovevano fare parte della massa callipolitana, attestata già nel VI secolo e sembra avesse seguito le sorti del territorio diocesano di Gallipoli almeno fino all’XI secolo. Si data a quel periodo un graffito (inciso sull’affresco del secondo pilastro a sinistra) in cui il prete Acindino pone il suo nome nel giorno della (ri)consacrazione della chiesa, avvenuta attorno all’anno mille, alla presenza di un vescovo della città ionica.
Una chiesa che mantiene saldo un forte legame con il passato, quella Casaranello dimenticata da tempo ormai e che sopravvive solo nel nome di questo luogo di culto. Un culto che affonda la sue radici al lontano concilio di Efeso e che ha vissuto da protagonista scismi e scandali prima di giungere fino a noi, in un’epoca nella quale, se pur consci della sua importanza, ci si dimentica dell’effettivo valore delle cose.
Marco Piccinni
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:
Un pontefice salentino: Bonifacio IX - Fede : rivista quindicinale d'Arte e di Cultura. - a. II, n. 3 (1 gennaio 1924).
Paul Arthur, Marco Leo Imperiale, Marisa Tinelli - Il Salento bizantino. Una guida archeologica. 2024, CLaudio Grenzi Editore
Stefano Cortese, Parallelismi iconografici tra la chiesa di S. Barbara di Montesardo e la chiesa di S. Maria della Croce di Casaranello, in “Controcanto. Rivista culturale del Salento” anno XIII n. 1 marzo 2017, pp. 3-4
Stefano Cortese, Casarano/La chiesa di santa Maria della Croce, in Progetto Salento n° 25, Felline, agosto 2012
www.sdomenico.net
www.vincenzosantoro.it



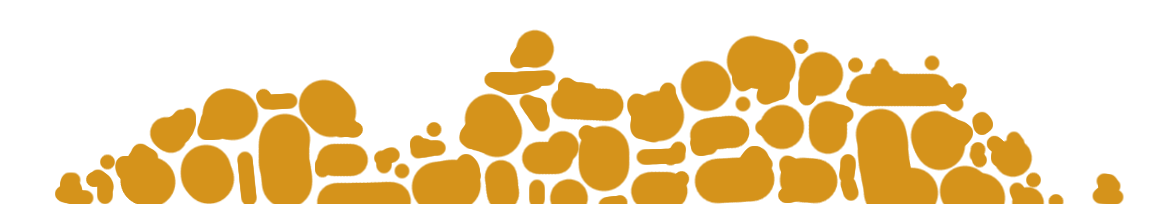

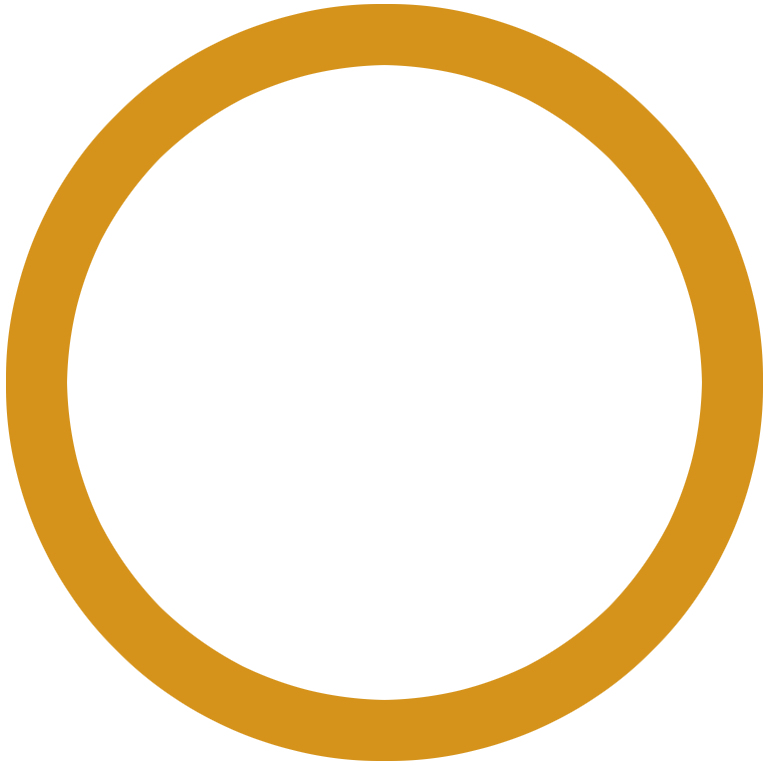
anche per questa chiesa chiedo : come posso visitarla ? a chi mi rivolgo ? GRAZIE x la risposta.
Questa chiesa è solitamente sempre aperta. Se è fortunato a trovare il custode le potrà raccontare anche un pò di storia.
Buongiorno, vorrei raccogliere ulteriori informazioni su questo antico luogo di culto che visitai l’estate scorsa. C’è qualcuno che può darmele?
Franco
Sito interessantissimo, guide gentili e preparate. Una visita da consigliare.
Da quello che ho capito, il mosaico a campana riscoperto da Arthur Haseloff non era quello esistente nel V secolo, ma fu modificato dai bizantini tra l’XI e il XIV secolo. Come era quello preesistente? Come si poteva conoscere all’epoca l’Empireo dantesco?
Il concetto di Empireo è espresso fin dai tempi di Aristotele. Il modello ripreso nella chiesa di Casaranello è quello che sarà poi ripreso da Dante nella Divina Commedia.